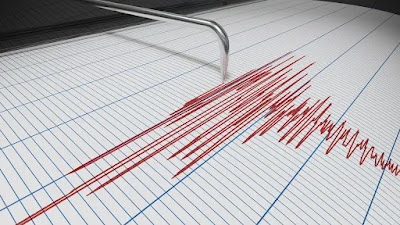A cura di Andrea Turi
Partiamo dagli recenti sviluppi che sono quelli di ieri (2 aprile 2013): l’ottava sessione del dialogo tra Serbia e Kosovo tenutosi a Bruxelles con la mediazione dell’UE doveva essere quello risolutivo. Si è concluso, invece, con un niente di fatto. Le chiedo: secondo Lei, un accordo è possibile?
In effetti un accordo è difficile e credo che richiederà tempi lunghi e condizioni giuste. Voglio dire, in fin dei conti la guerra del 1999 è terminata da meno di quindici anni che sono tanti ma, poi, non così tanti in una prospettiva storica, i risentimenti sono fortissimi e soprattutto sono ancora aperte le questioni “calde” che sono, per esempio, quelle delle minoranze serbe presenti in Kosovo e soprattutto nel Nord del Kosovo, la questione della sovranità del Kosovo che continua a non essere riconosciuto dalla Serbia come Paese sovrano così come da altri Stati europei, primo fra tutti la Spagna e per evidenti motivi, il fatto che permangano, comunque, delle minoranze albanesi nei territori del Sud della Serbia, il fatto anche molto doloroso sotto alcuni aspetti che in Kosovo siano locati alcuni dei luoghi cari alla memoria religiosa e storica serba perché bisogna ricordare che il Kosovo bene o male sia, il termine è stato utilizzato molto in passato in maniera retorica ma fotografa molto bene la realtà, la “culla” della civiltà serba e quindi dobbiamo pensare ai grandi monasteri ortodossi come quello di Pec che rimangono punti di riferimento ideali della cultura della Serbia. Questi, secondo me, sono gli elementi che ostacolano in modo evidente il processo di “normalizzazione” e lo ostacoleranno ancora nei prossimi anni assieme agli elementi psicologici e al risentimento per quello che è successo durante la guerra, durante e dopo, e che ovviamente da parte serba non può non essere forte. Comprendo le ragioni albanesi, non posso ignorare le ragioni di Belgrado che ha naturalmente perduto una guerra in cui si è vista sottrarre una parte di territorio che considerava nella sua prospettiva a buona ragione nazionale e che in quel territorio vede le proprie radici storiche.
Quindi, in sostanza, la mia non è una prospettiva ottimistica nel breve e medio periodo.
Secondo lei esiste un compromesso che possa essere accettato da entrambe le parti?
Se la volontà vera che sottostà al dialogo è quella di raggiungere un accordo, penso che un compromesso debba essere trovato perché altrimenti non vedo come se ne possa uscire. Per esempio, un compromesso potrebbe essere accettabile nei termini di una forte autonomia per non dire una vera e propria indipendenza delle province situate a Nord del Kosovo e quindi di garanzie forti nei confronti delle minoranze serbe e per i monasteri ortodossi sparsi nella regione che hanno una valenza storica e culturale rilevante. Più difficile è vedere cosa la Serbia possa e voglia poter dare in cambio al governo kosovaro albanese per ottenere vantaggi di questo tipo. Qui credo che il terreno si faccia molto scivoloso.
Torniamo al 1999. Quando scoppiò la guerra quali erano gli interessi nella regione? Perché era importante avere il controllo della regione?
I motivi reali della guerra si capiscono subito se si prende in mano una cartina geografica: il Kosovo è una regione situata proprio nel cuore della regione balcanica. Dal Kosovo, infatti, è possibile raggiungere un novero di Paesi che sono collocati intorno alla regione in questione; il Kosovo, inoltre, ha una notevole e fortissima valenza culturale e storica per l’Albania e gli albanesi. Quindi, il controllo del Kosovo consentiva, ed ha consentito, per esempio agli Stati Uniti tanto per non fare nomi, di situare lì una importante base militare, la più grande ed importante base militare statunitense all’estero. Ha consentito agli Stati Uniti di sviluppare un rapporto assolutamente privilegiato con l’Albania e con il popolo albanese sia dentro che fuori i confini dell’Albania. Consente agli Stati Uniti di esercitare un controllo e all’occorrenza anche una pressione sui vicini del Kosovo. Non credo, però, che la guerra per il Kosovo fosse dettata e sia stata il risultato di un calcolo, diciamo, strategico à la Risiko per impadronirsi di un territorio centrale ecc. Credo, piuttosto, che a quella guerra si sia arrivati perché, alla fine dei conti, ad un certo punto era la prospettiva considerata inevitabile da tutte le parti in causa: la Serbia pensava probabilmente che con il confronto delle forze di riuscire a raggiungere i suoi obiettivi di politica estera ma soprattutto di politica interna e penso a Milosevic; gli Albanesi pensavano di riuscire a raggiungere l’indipendenza; gli Americani pensavano di eliminare Milosevic per poter realizzare quell’ennesimo regime-change funzionale ad un intero progetto di politica estera statunitense; gli europei pensavano come al solito cose molto diverse e non essendo coesi sulla linea da seguire si sono allineati alla visione degli Stati Uniti. Tutto ciò è sfociato inevitabilmente nella guerra e nel risultato della divisione di Serbia e Kosovo, evento che da un certo punto di vista era scontato anche se non così scontato visto che se non ricordo male dall’aprile siamo arrivati sino alla fine di giugno (se non addirittura da marzo) e alla fine i Serbi hanno mollato anche per la forte pressione diplomatica esercitata dalla Federazione Russa. Quindi la situazione venutasi a creare non è stato soltanto il frutto di un’azione militare, intendo quella fondata sull’impiego del potere aereo, che ad un certo punto sembrava non riuscire a rivelarsi risolutiva tant’è che si era in procinto di effettuare un intervento per vie di terra che sarebbe stato problematico e costoso in termini umani.
In caso ancora l’avesse, qual è l’importanza oggi del Kosovo sullo scenario internazionale?
Ha un’importanza per gli attori direttamente coinvolti quindi per l’Albania ed evidentemente per la Serbia. Le recenti elezioni in Serbia e le prossime elezioni politiche che si terranno in estate in Albania bene o male hanno visto e vedranno una posizione centrale della questione del Kosovo che rappresenta per questi due Paesi una questione di un certo, per non dire molto, rilievo.
Interessante è quello che sta succedendo in Albania: il ritorno, cosa peraltro scontata per certi versi, dei progetti di Grande Albania, i riferimenti ormai espliciti in tanti pronunciamenti pubblici dei leader albanesi più importanti proprio alla prospettiva di una progressiva integrazione delle regioni del Kosovo nello Stato albanese che, naturalmente, se questo avverrà, potrebbe mettere in moto, come è già avvenuto, dei processi di risveglio albanese in tutti quei Paesi vicini in cui rilevante è la componente albanese, penso alla Macedonia, alla stessa Grecia della zona dell’Epiro, penso alla zona del Montenegro. Per la Serbia è una questione particolarmente delicata, una questione che ha a che fare con la sovranità nazionale, la Serbia ha patito quella che considera una umiliazione ed una ingiustizia ed è evidente che questa cosa più o meno sotto traccia a prescindere, insomma, dall’enfasi che ad essa danno i diversi leader ed esponenti politici serbi pesa e continuerà a pesare.
Dacic ha dichiarato a metà marzo che Pristina non è ancora pronta ad un accordo perché ha le spalle coperte dal potere statunitense. Lei poc’anzi ha già espresso la centralità della regione per Washington. Dato per certo il ruolo degli Stati Uniti in Kosovo, Le chiedo se, oggi, la Federazione Russa può avere un ruolo da protagonista in Kosovo e, più in generale, nella regione balcanica.
La Federazione Russa un ruolo da protagonista sul palcoscenico balcanico lo ha avuto e credo che continuerà ad averlo. D’altra parte la Federazione Russa fa parte dei famosi BRICS, è un Paese in espansione economica, che gode grazie alle risorse naturali di possibilità economiche, che significano anche possibilità di pressione politica, rilevanti. Però, che questo, nel breve e medio periodo consenta, come dire, di bilanciare la situazione mettendo la Serbia, dal punto di vista negoziale e diplomatico, sullo stesso piano del Kosovo mi sembra improbabile. Anche perché non credo che la Federazione Russa si voglia spendere più di tanto per una causa che, temo, sia perduta. La Serbia in questo momento è in una posizione di grande debolezza: è rimasta isolata dopo la guerra, lo è per certi versi tutt’ora. È chiaro che l’Albania è in una posizione tutta diversa. È vero quanto da lei riportato che l’Albania e in particolare intendo il Kosovo albanese e il suo governo si trovi in una posizione di forza perché evidentemente alle loro spalle ci sono gli Stati Uniti.
Non altrettanto chiaramente dietro il Governo di Belgrado e le sue richieste vedo la Federazione Russa perché appunto rimanendo verissima la solidarietà che i russi hanno sempre dimostrato in questi ultimi anni nei confronti della Serbia e anche durante il conflitto, o subito dopo, non so quanto vogliano e si possano spendere per la causa serba e non so se questo è nell’interesse prioritario della Federazione Russa.
E l’Unione Europea che interesse ha nella regione in generale ed in Kosovo in particolare?
L’Unione Europea nella regione balcanica ha sempre avuto…anzi, meglio, l’Unione Europea nella regione balcanica avrebbe sempre dovuto avere un interesse che era quello di evitare la destabilizzazione dell’area, di evitare l’aumento della conflittualità e che, soprattutto, la conflittualità scattasse a livello violento. Purtroppo, a partire dagli anni ottanta e i primissimi anni novanta l’Europa si è presentata spesso, quasi sempre, divisa e poco efficace da un punto di vista diplomatico su quello scenario. Le conseguenze le conosciamo: in fin dei conti, anche il fatto che la crisi scoppiata nell’ex Jugoslavia nel momento in cui la Federazione si trovò coinvolta in quel cataclisma geopolitico che era stato la fine della guerra fredda e il crollo del Muro con quel che ne è conseguito, andare fuori controllo di quella situazione fu dovuta anche a certe iniziative, più o meno affrettata, di rilevanti attori dello scenario politico europeo a cominciare probabilmente dalla stessa Germania: i riconoscimenti affrettati, non concordati con i partner e così via.
Non mi sembra, ad essere onesto, che le cose da allora siano cambiate molto a prescindere dal fatto che ci sia adesso Lady Ashton e una presunta politica estera condivisa. L’Europa politica vive un momento di grande crisi, inutile nascondercelo, e che quindi riesca, possa e voglia nel futuro immediato, in particolare qualora si verificassero nuove crisi locali, e spero che questo non avvenga, giocare un ruolo maggiormente significativo del ruolo giocato in passato mi sembra improbabile, non vedo gli elementi che potrebbero giustificare un’asserzione, un’affermazione di questo tipo.
Lo intravede un futuro europeo di Serbia e Kosovo? Crede che l’opzione europea sia quella cui ambiscono i due Governi oppure ci sono altre opzioni?
Mah, fino a pochi anni fa avrei detto che l’opzione europea fosse un’opzione pressoché obbligata. Sia per ragioni, se vogliamo, ideali, storiche e culturali perché evidentemente stiamo parlando di territori che sono a buon diritto e a buona ragione europei, che sono nel cuore dell’Europa, che sono strettamente legati alla storia dell’Europa, anche se per secoli sono stati territori di confine e territori che sono stati sotto il controllo di una potenza, l’Impero Ottomano, che non era potenza europea. Indubbiamente, nei primi anni novanta, il riferimento di tutta quell’area geopolitica dei Paesi balcanici che uscivano da decenni di regimi comunisti era ed è stata l’Europa. Indubbiamente c’è stata un’ondata di entusiasmo che ha preceduto, accompagnato e seguito l’ingresso in Europa di Paesi di quell’area come la Romania o più a Nord la Polonia.
Nel frattempo, però, sono cambiate tante cose. Sono cambiate tante cose perché il progetto europeo di integrazione è in crisi, molti Stati europei, in particolare quelli che sono più vicini per vari aspetti di natura geografica e culturale agli Stati balcanici, sono quelli che in questo momento si trovano in grave crisi economica e finanziaria all’interno dell’Unione. Al tempo stesso c’è stato, a partire dall’anno 2000, un evidente risveglio e il manifestarsi di una politica estera e di difesa molto muscolare da parte della Federazione Russa che è chiaro è legata a quei popoli, in particolare al popolo serbo da vincoli storici e culturali di antica data, mentre a Sud c’è un risveglio di tipo neo-ottomano: la Turchia è un Paese che sta bruciando le tappe sulla via dello sviluppo, è un Paese in enorme crescita, che ha sfiorato il 6% di incremento annuo del PIL dal 2007 ad oggi, cioè, negli anni di peggior crisi per l’eurozona. L’Euro è una moneta, in questo momento, forte ma l’area economica cui essa fa riferimento non è altrettanto forte in tutte le sue componenti. Cresce l’euroscetticismo, sia all’interno di Eurolandia che, ovviamente, fuori dai confini di Eurolandia. Gli stessi turchi, per esempio, che fino a qualche anno fa erano particolarmente ansiosi ed esercitavano forti pressioni per entrare in quella che poi è diventata l’Unione Europea oggi mi paiono molto più prudenti e scettici e, alla fine, abbastanza disponibili anche a rimanerne fuori visto che sono stati tenuti alla porta a lungo e oggi vedono venir meno di, non dico tutte, alcune condizioni che li avrebbero resi entusiasti partecipi del processo di costruzione europea.
Quindi, se mettiamo assieme tutte queste cose, oltre alle crisi locali come ad esempio i risentimenti serbi nei confronti dell’Europa specie nei confronti di alcuni Stati dell’Europa e che, penso alla Spagna, ci siano risentimenti di alcuni stati europei su come è stato risolto il conflitto serbo – albanese sul Kosovo, tutto questo, dicevamo, delinea un quadro che mi fa dire che quella europea sia l’unica opzione anche se, personalmente, potrei anche auspicare un ulteriore allargamento dell’Unione europea in quell’area eccetera. Però, realisticamente, ci sono tutte queste condizioni nuove che lo rendono molto più difficile.
Chiudo con questa domanda: possibile un nuovo atto di forza per risolvere la questione?
Un atto di forza potrebbe essere pericoloso e controproducente. Non credo che la Serbia, poi, si trovi in condizioni economico-politiche tali da permetterle nuove avventure. Tutto questo mi lascerebbe propendere per affermare che tutto è possibile in politica ma che ci sono cose molto poco probabili.
Firenze, 3 aprile 2013.
*Luciano Bozzo, Professore associato, insegna Relazioni Internazionali e Studi Strategici nel Corso di laurea triennale in “Studi internazionali” dell’Università di Firenze. Insegna inoltre nei Corsi di laurea specialistica in “Relazioni internazionali” e in “Scienze aeronautiche”, al Master in “Comunicazione e Media” dell’Università di Firenze e al Master in “Human Rights and Conflict Management” della Scuola Sant’Anna di Studi Universitari e Perfezionamento di Pisa. È Direttore del Centro universitario di Studi Strategici ed Internazionali (CSSI), costituito presso il Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia. Insegna dall’a.a. 1990-1991 Strategia Globale al Corso superiore della Scuola di Guerra Aerea di Firenze. E’ membro dell’International Institute for Strategic Studies di Londra. Ha partecipato come caposquadra alla missione di monitoraggio delle elezioni amministrative in Albania nel 1996. Nel periodo 1998-2001 è stato a più riprese impegnato in Bosnia, nel quadro delle attività per l’applicazione degli accordi di Dayton.
![Share on Facebook facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()
![Share on Facebook facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()